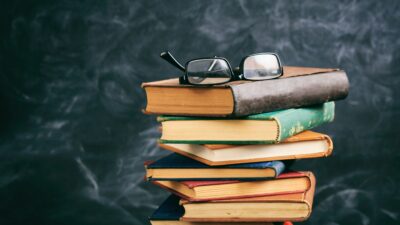Diciamolo: quando sentiamo la parola “dati”, molti di noi pensano subito a fogli Excel, dashboard, numeri ordinati in colonne precise. Ma per Ana Talavera, i dati sono molto più simili a una storia: vivi, stratificati, umani. Qualcosa da sentire, non solo da misurare.
Con oltre tredici anni di esperienza nella cultura digitale, nel comportamento dei consumatori e nell’intelligenza dei dati, Ana non si limita a interpretare numeri: li ascolta. Ne segue i fili tra cultura, linguaggio, movimento, silenzi e sfumature sociali. Il suo approccio vive all’incrocio tra tecnologia, psicologia e comunicazione. E riesce a rendere l’analisi della complessità un gesto di curiosità, non di controllo.
Cresciuta in Brasile da un’insegnante di matematica e una psicologa, Ana ha imparato presto a muoversi tra logica ed emozione, tra struttura e flusso. Questa dualità è diventata la lente con cui guarda (e interroga) tutto: le narrazioni, i pattern, i nodi culturali che spesso passano inosservati.
Prima di diventare una delle professioniste più riconosciute nel campo della social intelligence (inserita per due volte tra i nomi da tenere d’occhio dal Social Intelligence Lab), Ana è stata anche una ballerina – una dimensione che ancora oggi modella il suo sguardo sul mondo. Perché nella danza, come nei dati, ogni dettaglio conta. Ogni silenzio parla. Ogni gesto ha un significato.
Ha lavorato con brand come Meta, Netflix, Heineken, sempre con lo stesso obiettivo: umanizzare i numeri, far sì che l’insight prenda vita. Il suo toolkit mescola neuroscienze, psicologia sociale, analisi linguistica e ricerca culturale, perché se vogliamo davvero capire le persone, servono più delle metriche. Servono storie, contesto, presenza.
Ana è anche l’autrice di Fio da Meada, una newsletter bisettimanale brillante, ispirata all’espressione brasiliana “perdere il filo della meada” – un modo di dire per indicare di aver perso il filo del discorso. Ma come scrive lei stessa, forse perdersi fa parte della magia. In fondo, è nel disordine, nei microsegnali, nelle contraddizioni che accade davvero la cultura.
Qui su The Buns l’abbiamo incontrata per parlare della vita emotiva dei dati, di identità ibride, empatia digitale e di cosa sta scoprendo seguendo il filo, un’intuizione alla volta.
Benvenuta Ana! Il tuo approccio ai dati è pieno di sentimento: preciso, ma mai freddo. Cosa significa per te “umanizzare i dati”? E come possono i brand andare oltre le metriche per ascoltare davvero quello che le persone stanno cercando di dire?
Per me, umanizzare i dati è ricordarsi che dietro ogni numero c’è qualcuno che sta vivendo una storia – non solo mettendo in atto un comportamento. Ogni click, ogni like, ogni carrello abbandonato contiene molto più di un semplice dato: è un gesto carico di contesto, intenzione, contraddizione. E la domanda che continuo a farmi è: stiamo davvero analizzando la cultura, o ci stiamo solo limitando a quantificare il comportamento? Contare le azioni è facile. Il vero lavoro – quello umano – è interpretare cosa rivelano quelle azioni su chi siamo, sulle paure, i desideri, i valori che ci modellano.
Se i brand vogliono davvero ascoltare, devono smettere di leggere le dashboard come fossero testi sacri e iniziare a sintonizzarsi sugli strati più disordinati e silenziosi: quello che succede tra un post e l’altro, nelle pause, nello spostamento delle conversazioni verso spazi privati. È lì che i dati respirano – smettono di essere report statici e diventano parte viva e mobile della cultura. Ed è proprio in quello spazio, pieno di tensione ed emozione, che i brand hanno la possibilità di contare davvero.
Hai lavorato tra Brasile, Stati Uniti ed Europa. In che modo questa fluency culturale modella le tue intuizioni? Ti è mai capitato che lo stesso dato raccontasse storie completamente diverse, a seconda del contesto culturale?
Onestamente? La cosa più grande che ho imparato lavorando tra Brasile, Stati Uniti ed Europa è che… i dati hanno un accento. Sembra assurdo, ma è così. La cultura cambia tutto – è come un filtro che colora ogni numero, ogni grafico, ogni “insight” che pensiamo di leggere. E lo vedi nella vita reale. Quello che in Brasile sembra entusiasmo puro, negli Stati Uniti può essere una forma di protesta. In Europa? A volte prende la forma di una distanza fredda e ironica. Stessa impennata nei commenti – storie completamente diverse, a seconda di chi c’è dall’altra parte dello schermo. Mi ha fatto capire una cosa: i dati non decidono nulla da soli. Puoi (e devi) usarli per orientarti, ma non puoi lasciargli il volante. I dati sono una mappa, non il guidatore.
La comprensione reale arriva solo quando ci metti una lente umana – quando hai abbastanza curiosità da chiederti perché, e non solo cosa. Se non lo fai, stai solo contando numeri nel vuoto. Ti perdi gli strati, le emozioni, i significati che muovono davvero le persone. Senza contesto, i dati sono solo rumore travestito da certezza. E quando guardi ai comportamenti globali? Dimentica per un attimo il foglio Excel. Un singolo numero non racconta mai tutta la storia. Devi leggere tra le righe – cogliere il senso di appartenenza, l’identità, quei codici invisibili che fanno scattare le persone, ridere, resistere, sparire. Alla fine, lavorare con i dati è come tradurre una lingua fatta per metà di numeri, per metà di battiti. Non conta solo cosa fanno le persone – ma cosa significa quando lo fanno.
La tua newsletter, Fio da Meada, è una metafora bellissima — seguire fili, perdersi, scoprire cose che non si stavano cercando. C’è un filo che stai seguendo in questo momento e che ti sta sorprendendo?
Ultimamente sto tirando il filo di qualcosa che chiamiamo nostalgia digitale — o, per essere più onesti, nostalgia algoritmica. In un mondo ubriaco di innovazione, è quasi comico vedere come la tecnologia continui a riportarci indietro. Adolescenti che non hanno mai toccato un VHS stanno romanticizzando i filtri delle videocamere. Gli anni ’90 sono più di moda che mai — su app progettate per far fuori qualsiasi cosa “vecchia” prima di colazione. Ma non prendiamoci in giro: questa non è memoria. È solo un altro prodotto. Non stiamo ricordando il passato — ce ne stanno vendendo una versione riscaldata, ottimizzata per l’engagement.
E, visto che il 2025 ama i colpi di scena, è entrata in scena anche l’AI. Sì, l’intelligenza artificiale può sfornare meme più in fretta di quanto tu possa dire “feed refresh”. Ma riesce a catturare la bellezza tragicomica e disordinata del perché facciamo i meme, in primo luogo? Nemmeno per sogno. In realtà ho studiato questo tema – la psicodinamica dei meme brasiliani – e spoiler: non si tratta solo di battute. È umorismo come forma di resistenza (“Come sopravvivere al 2025 senza vendere un rene?”), frustrazione che esplode in meme di disperazione esistenziale (“È di nuovo lunedì”), desiderio trasformato in sogni di vincere alla lotteria o scappare in Europa, e speranza – una speranza testarda, ruvida – che filtra fuori in punchline ironiche (“benedetto chi ha la pazienza di un brasiliano”).
In Brasile, i meme non sono contenuti. Sono istinto di sopravvivenza. E questo, l’AI non lo può automatizzare. Può individuare pattern. Può generare battute. Ma senza il glitch, il caos, il cuore spezzato nascosto dentro una risata? È solo rumore sterile. Alla fine, non stiamo scrollando i nostri ricordi. Stiamo scrollando ciò che l’algoritmo ha deciso che è sicuro ricordare — servito fresco ogni giorno, ma senza anima. Eppure, tra un ricordo riciclato e l’altro, ridiamo. Forte, confusamente, umanamente. E, onestamente? Quella risata è l’unica cosa che la macchina non può ancora rubarci.
Il data storytelling è ormai una buzzword, ma tu lo fai da ben prima che diventasse di moda. Cosa rende davvero efficace una storia di dati – soprattutto in un’epoca in cui siamo tutti sommersi dalle informazioni?
Se c’è una cosa che ho imparato lavorando con i dati, è che non stiamo vendendo numeri. Stiamo cercando di raggiungere le persone. Persone che non decidono sempre in modo razionale. Piene di desideri, dubbi, distrazioni – e a un battito di ciglia dal passare alla slide successiva. Per questo, mettere insieme un dato dopo l’altro, senza tensione, ritmo o emozione, è il modo più rapido per essere dimenticati prima ancora che lo schermo svanisca. Raccontare una storia di dati, per me, significa intrecciare un filo invisibile tra ciò che voglio mostrare e ciò che le persone hanno bisogno di sentire.
Significa usare il tono come uno strumento: a volte per accendere urgenza, a volte per invitare alla riflessione, a volte per portare un respiro di speranza nella stanza. Scegliere il dato giusto non basta — serve costruire la narrazione con intenzione. Quale dato viene per primo? Dove creo tensione? Qual è il numero che colpisce allo stomaco? E quale dà alle persone un motivo per restare fino alla fine? Un buon racconto di dati non dà risposte facili. Fa nascere le domande giuste. E per farlo, devi costruire la storia con ritmo — sapere cosa enfatizzare, cosa ammorbidire, e cosa lasciare rimbalzare nella testa di chi ascolta, dopo l’ultima parola.
Quando presento dei dati, non penso a “informare”. Penso a creare piccole frizioni: momenti in cui qualcuno, tra il pubblico, sente un disagio, una scintilla, una pausa. Perché alla fine, nessuno ricorda la tabella che hai proiettato. Ricordano cosa li ha colpiti — prima che tu cliccassi sulla slide successiva.
E per finire: se i dati fossero un personaggio di una storia – una figura viva, che respira – come lo descriveresti? Che aspetto avrebbe, che voce, che movimenti? E cosa vorrebbe farci capire, più di ogni altra cosa?
Se i dati fossero una persona, sarebbero come Fleabag. Intelligenti, affascinanti, con il tempismo perfetto per una battuta – e sotto sotto, un disastro totale. Il tipo di persona che illumina una stanza mentre si sta lentamente sgretolando.
I dati, oggi, non sono stabili né trasparenti. Indossano ogni giorno il costume che l’algoritmo richiede: si fanno teatrali quando devono vendere, spariscono quando la verità pesa troppo. La maggior parte del tempo, stanno solo cercando di sopravvivere al caos, come qualcuno bloccato a una cena di famiglia già andata completamente fuori controllo. Da lontano sembrano puliti — grafici ordinati, numeri allineati, tutto al posto giusto. Ma se ti avvicini, inizi a vedere le crepe, le scorciatoie, i modi in cui si piegano quel tanto che basta per adattarsi a un mondo che premia la velocità più della precisione.
I dati non danno risposte. Trattano. Ti offrono pezzi, ne nascondono altri, ti fanno un sorriso rapido e chiedono: “È questo che volevi sentirti dire?” E quasi sempre, sì. L’algoritmo ha imparato in fretta: la gente non vuole la verità, con tutto il suo disordine. Vuole numeri che li facciano sentire nel giusto. Così i dati servono visual comode, statistiche preconfezionate, certezze pronte all’uso. Ma se potessero rompere la quarta parete, come fa Fleabag, non ti implorerebbero di crederci. Si avvicinerebbero, con un sorriso di lato, e direbbero: “Io ho senso solo perché tu hai bisogno che ne abbia.” I buoni dati non danno conforto. Ti fanno congelare per un attimo. Ti fanno esitare prima di cliccare sulla prossima slide.
Alla fine, i numeri sono solo la cornice. Il modo in cui dipingi il quadro – o lo rovini – dipende sempre da te.