C’è stato un momento in cui l’Italia si è fermata. Non per una finale dei Mondiali, non per Sanremo, nemmeno per le elezioni politiche. È stato per il conclave. Un rituale antico, lento, carico di simboli e mistero. Eppure, anche chi non ha mai messo piede in una chiesa – o l’ha fatto solo per i matrimoni degli altri – si è ritrovato a seguire la diretta da Piazza San Pietro, a controllare su X il gabbiano sul comignolo e la fumata in arrivo, a chiedersi chi sarebbe stato il nuovo Papa, come se fosse l’ultima stagione di una serie di culto o l’annuncio del vincitore di Masterchef. Ma perché? Perché un evento profondamente religioso, radicato nel cuore della Chiesa cattolica, ha catturato l’attenzione di chi della religione non sa che farsene?
Intanto, la vera sorpresa è che le risposte sono racchiuse dentro segnali che non arrivano solo dai palinsesti ufficiali o dai telegiornali. Basta osservare da vicino i social, le chat, i meme, perfino le community più lontane dal mondo ecclesiastico. Gli small data sono ovunque: nel tweet di chi ironizza sul gabbiano appollaiato sul comignolo come fosse un presagio, nel meme che paragona i cardinali a concorrenti di un reality, nei gruppi Telegram dove si scommette sul nome del futuro Papa come fosse una finale di Champions. Sono indizi leggeri ma eloquenti, tracce digitali che ci dicono una cosa semplice: anche chi non crede si è lasciato coinvolgere.
Il bisogno di riti collettivi, anche senza fede
Forse è perché siamo orfani di riti. In un mondo dove tutto accade in tempo reale e in differita allo stesso tempo, dove non c’è più l’appuntamento fisso con niente (nemmeno con i telegiornali), eventi come il conclave si impongono come rare liturgie collettive. Guardare insieme una canna fumaria, aspettare una fumata, sospendere il tempo – tutto questo sembra assurdo nel nostro presente iperconnesso e iper-cinico. Eppure funziona. E ci riguarda. Viviamo immersi in mille micro-nicchie culturali, ma poi succede qualcosa che ci riunisce tutti davanti allo stesso schermo: bianco o nero? Esce o non esce? Chi sarà? È come un Super Bowl dell’anima, ma a basso volume. Non è tanto il Papa. È il rito. È il gesto simbolico. È l’attesa. È la sensazione che il mondo intero stia guardando nello stesso punto.
Il cattolicesimo culturale: ci crediamo anche se non ci crediamo
In Italia la religione è un codice culturale, prima ancora che una questione di fede. Cresciamo tra chiese, campanili, processioni, battesimi e funerali dove si va “perché si fa”. Anche se ci siamo dichiarati atei, anche se votiamo partiti laici, anche se non sappiamo il Padre Nostro, continuiamo a parlare di “miracoli”, “peccati”, “resurrezioni” in senso lato. Usiamo l’aggettivo “papabile”. Quando si elegge un Papa, quel codice culturale si riattiva. Non come credenti, ma come spettatori di un linguaggio che conosciamo a memoria, anche se l’abbiamo disimparato. E poi, inutile negarlo: c’è anche un po’ di orgoglio nazionale. Il Vaticano è a Roma, i cardinali si chiudono in conclave da noi, le immagini che girano il mondo arrivano da una piazza che tutti conoscono, ma che per noi è un paesaggio quotidiano.
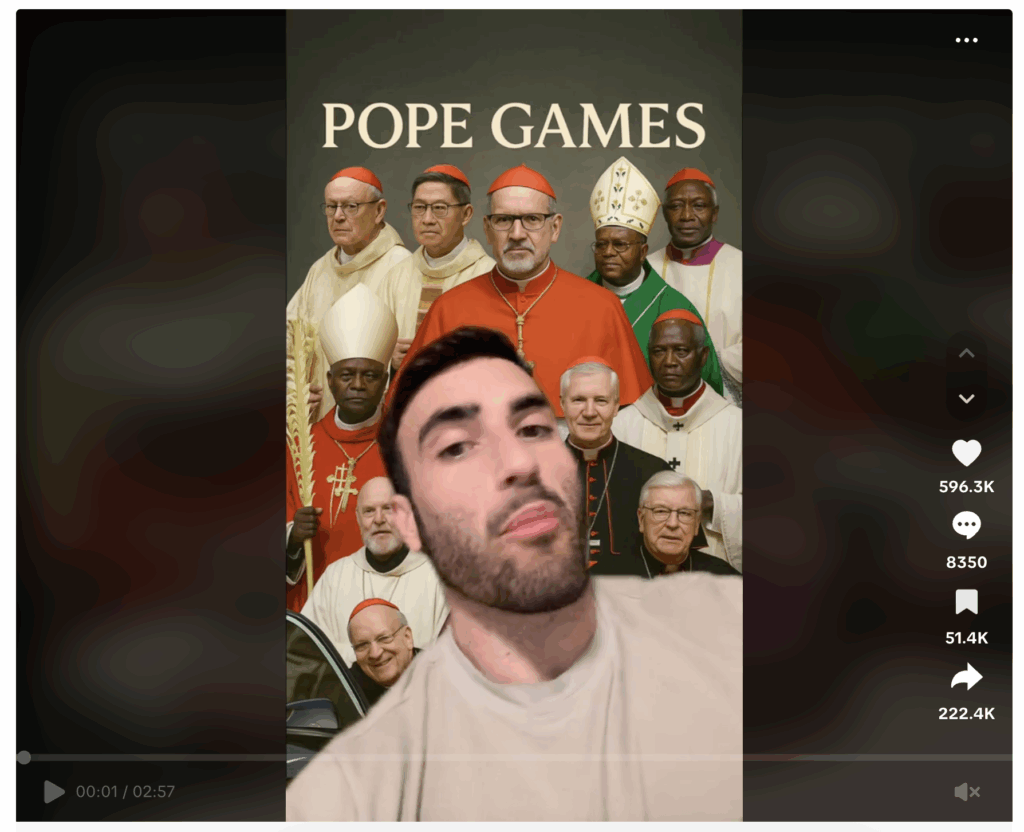
Il conclave come racconto: personaggi, simboli, colpi di scena
Il conclave ha una struttura narrativa perfetta. C’è il mistero: chi sarà il prescelto? C’è l’intrigo: le fazioni, i giochi di potere, i nomi in pole position che poi svaniscono. C’è il simbolismo: la chiusura delle porte, la fumata, l’Habemus Papam. E c’è il colpo di scena finale: un nome, un volto, un linguaggio del corpo tutto da interpretare. Non serve essere credenti per riconoscere che qui si muove una macchina narrativa potentissima. Una serie in più stagioni che va avanti da secoli. E noi, anche se siamo scettici, finiamo per farci coinvolgere. Non per fede, ma per fame di racconto.
Il potere e la nostalgia di una voce autorevole
In un’epoca in cui la politica è sfilacciata, i leader sembrano piccoli amministratori di emergenze e il linguaggio del potere è tutto tecnico, il Papa – ogni Papa – resta una figura simbolica con un peso globale. Non governa uno stato qualunque. Governa un’idea. Rappresenta, nel bene e nel male, una voce che può ancora dire parole grandi: pace, giustizia, compassione, umanità. Anche chi non crede, a volte, cerca disperatamente qualcuno che dica qualcosa con un minimo di visione. Non necessariamente per aderire, ma per sentire che da qualche parte qualcuno prova ancora a parlare all’umano. E allora sì, ci interessa chi sarà. Se sarà giovane o anziano. Aperto o conservatore. Se vorrà cambiare le cose o tenere la barra dritta. Perché anche se non ci riguarda “religiosamente”, ci riguarda culturalmente, politicamente, socialmente. Come ogni grande simbolo collettivo.
Il mistero come antidoto alla trasparenza forzata
Viviamo tempi iper-razionali e iper-trasparenti. Tutto viene spiegato, mostrato, commentato. Il conclave, invece, resiste. Si entra, si chiudono le porte, si vota. Nessun video. Nessuna dichiarazione. Nessuna stories da dentro la Cappella Sistina. Solo silenzio, speculazioni, segreti. È un gesto quasi eversivo nella sua opacità. E proprio per questo, affascina.
Perché ci ricorda che non tutto può (o deve) essere detto. Che il mistero ha ancora un posto. E che forse, nel profondo, ne abbiamo bisogno.
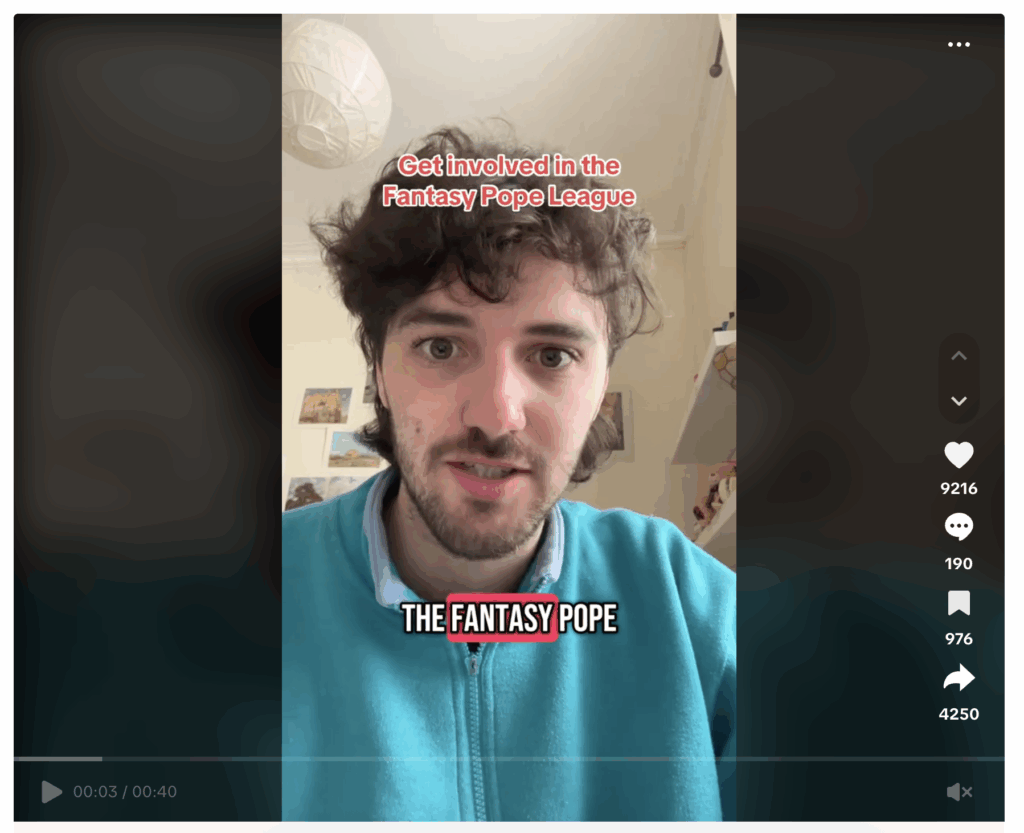
Un Papa è anche un corpo
Non dimentichiamolo: la Chiesa è fatta anche di incarnazione. Il Papa, ogni volta, è un corpo. E quando esce sul balcone, quel corpo dice moltissimo. Se è ha lineamenti occidentali oppure orientali, se cammina con passo sicuro o esitante, se sorride o appare commosso, se parla solo in latino o si rivolge al mondo con parole semplici. È tutto gesto, immaginario, rappresentazione. In un’epoca in cui siamo sempre più digitali, disincarnati, spettatori filtrati di avatar e contenuti, vedere un essere umano in carne e ossa che assume simbolicamente un ruolo così carico ha un impatto forte. Per molti di noi è l’unico momento in cui prestiamo davvero attenzione al linguaggio del corpo, alla ritualità, alla lentezza di un’apparizione.
Non serve credere per lasciarsi toccare
Alla fine, tutto questo – l’attesa, il silenzio, la fumata, il nome nuovo, il volto che si affaccia – non richiede fede. Richiede solo presenza. Guardare il conclave da atei, da agnostici, da spettatori scettici, non è un paradosso. È un segnale dei tempi. Siamo disillusi, ma non disinteressati. Non cerchiamo una salvezza, ma forse un senso. Non chiediamo miracoli, ma storie potenti, gesti collettivi, qualcosa che unisca invece di dividere. E allora sì, anche voi – anche noi – che pensavamo di essere lontani anni luce da tutto questo, ci siamo fermati per guardare. Non per fede. Perché, in fondo, davanti a una fumata bianca che si alza, un po’ tutti vogliamo credere – anche solo per un attimo – che qualcosa di nuovo sia possibile.







