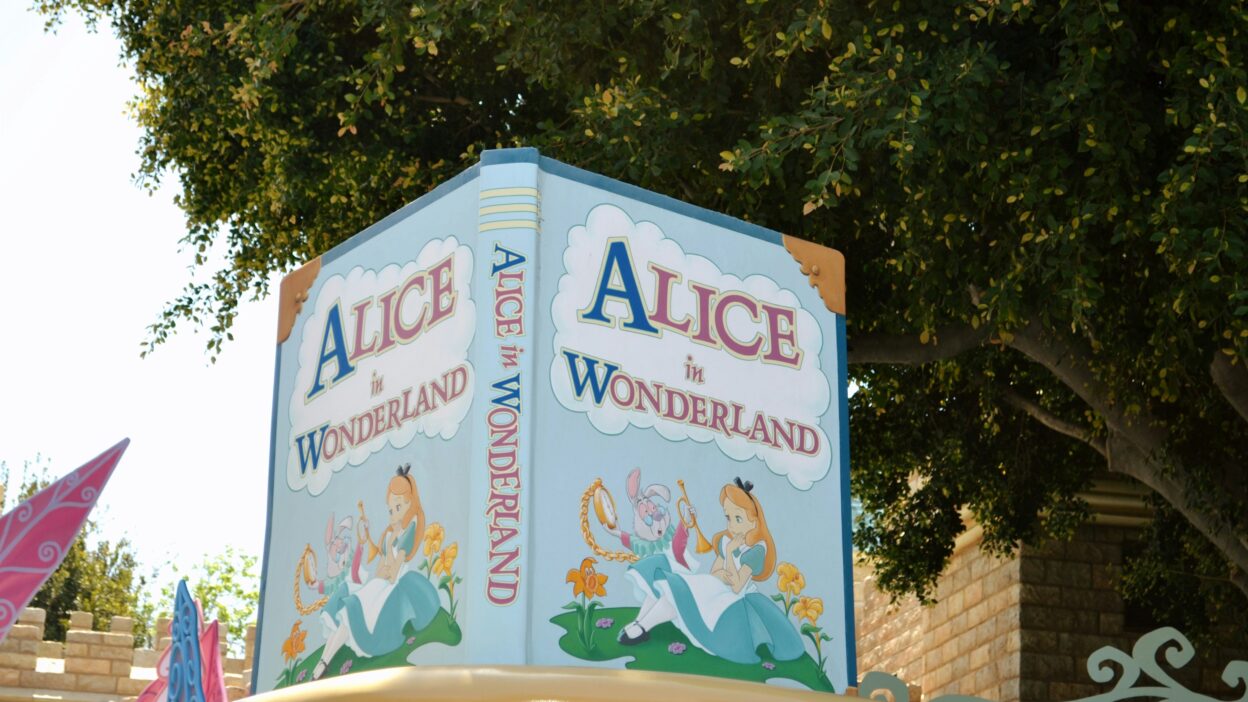Di che materia è fatta la meraviglia? Alice la afferra, la seziona, la interroga. Non la subisce: la esplora. In un mondo in cui tutto cambia di continuo – regole, misure, linguaggi – lei non smette mai di fare domande. E se vi sembra solo una storia per bambini, vi sbagliate di grosso. Ogni anno il 4 luglio si celebra l’Alice Day, giorno in cui Lewis Carroll, nel 1862, iniziò a raccontare la sua storia. Ed è proprio qualche giorno fa che è nato anche HyperKids, la nuova costola di Hypercritic dedicata all’infanzia (ma rivolta agli adulti). Perché Alice è più di un personaggio: è un mindset.
Alice non è solo una sognatrice: è una ragionatrice. Sembra capitare per caso in un universo assurdo, ma la sua risposta al nonsense non è la fuga, è l’indagine. Osserva, deduce, confuta. È una precursora del pensiero computazionale, una hacker in gonnella vittoriana. I suoi strumenti? Il paradosso, il gioco di parole, il linguaggio matematico, il problem solving. Chi ha detto che la meraviglia debba essere irrazionale? Alice, con la sua curiosità ostinata, ci insegna che si può essere logici e poetici, precisi e immaginativi, scientifici e pieni di stupore. È questo che la rende, a pieno titolo, una bambina STEM: non tanto perché sappia usare strumenti scientifici, ma perché incarna l’approccio scientifico stesso.
Eppure, di bambine come Alice, nella realtà, se ne raccontano ancora troppo poche. Meno del 20% delle biografie in lingua inglese su Wikipedia riguarda figure femminili. Questo dato ha spinto lo Smithsonian American Women’s History Museum, insieme a Wikimedia DC, a organizzare un Wikipedia Edit-a-thon per scrivere e aggiornare voci dedicate a donne americane dimenticate.
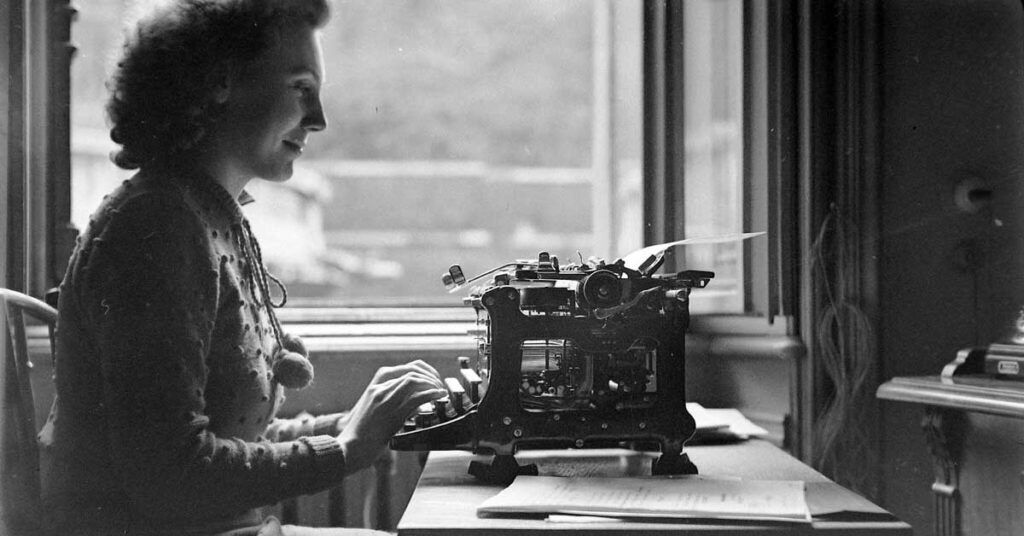
Dal 2017 la fisica britannica Jess Wade è impegnata a colmare questo gap. Ha scritto centinaia di voci su scienziate e ingegnere, portando avanti una battaglia concreta: senza dati non c’è memoria, e senza memoria non c’è rappresentazione. Ma il problema è globale.
In Giappone, molte aziende tech faticano a trovare talenti femminili, non per mancanza di competenze, ma per la scarsissima presenza di donne nei percorsi STEM. Colpa di retaggi culturali, aspettative di genere e stereotipi ancora duri a morire. E mentre l’intelligenza artificiale genera sconvolgimenti nel mercato del lavoro, si fa strada un dato chiaro: le competenze STEM da sole non bastano più. Secondo David Deming, docente di Public Policy ad Harvard, i lavori che combinano skill matematiche e sociali sono cresciuti molto più di quelli puramente tecnici. Ecco perché parlare di Alice oggi significa parlare di STEM + soft skills. Curiosità, logica, ma anche linguaggio, empatia, pensiero laterale.
A scuola, sul lavoro, nel modo in cui cresciamo i bambini: serve un cambio di paradigma. Aggiungere la A di Arts alla formula STEM significa trasformarla in STEAM, un modello educativo che integra le competenze scientifiche con quelle artistiche e umanistiche. Non è una moda, ma una necessità. Lo dimostrano i numeri: gli studenti con doppia laurea in ingegneria e discipline umanistiche guadagnano in media il 3,6% in più rispetto ai soli STEM. E chi ha studiato arte e poi ha aggiunto un modulo business o tecnologico è più creativo, più flessibile, più pronto al cambiamento. Nel futuro del lavoro, quello in cui le macchine fanno i conti più velocemente di noi, ciò che resterà umano sarà ciò che è unico.

Rileggere Alice nel Paese delle Meraviglie nel 2025 significa anche questo: trovare un modello alternativo di intelligenza. Una bambina che non vuole diventare una principessa, ma che si perde per scoprire. Che non cerca l’ordine perfetto, ma il significato nascosto. Che non fugge dalle stranezze, ma ci si tuffa dentro con metodo. E forse, a ben guardare, è proprio questo il futuro della cultura: una scienza che sa meravigliarsi, un pensiero critico che sa giocare. Perché come ci insegna Alice: “È inutile cercare di ragionare con chi non vuole usare la ragione. Ma puoi sempre porgli una domanda assurda.”
È proprio da queste riflessioni che nasce HyperKids, il progetto di Hypercritic (non nuovo alla contaminazione) che usa i mondi dell’infanzia per raccontare quelli degli adulti.Libri illustrati, giochi, frasi rubate, piccole grandi verità. Tutto si mescola in un canale Instagram fatto per chi non ha paura di stupirsi, né di sembrare ridicolo. Si usano gli strumenti del mondo bambino per osservare la complessità adulta. Non per semplificarla, ma per guardarla da un’altra altezza.

Su HyperKids ci si perde volentieri tra libri illustrati che sembrano per bambini, ma che in realtà parlano anche (e soprattutto) a noi adulti. Storie di lupi ansiosi, gatti ribelli, bambine filosofe e piccoli robot che non sanno più spegnersi. Vengono raccolte frasi che i bambini dicono e gli adulti dimenticano, e vengono trattate come indizi, segnali, frammenti di poesia quotidiana. Si guardano i giocattoli come se fossero dispositivi critici: un peluche non è mai solo un peluche. A volte è un modo per parlare di identità, di confini, di corpo. E sì, anche di politica.
Non solo: si collezionano mostriciattoli emotivi da adottare e da cui lasciarsi adottare: vergogna, gelosia, entusiasmo, paura, curiosità. Nessuno viene escluso. E poi ci si perde per le cittá con piccole guide urbane pensate per occhi che si allenano a notare le cose invisibili: una faccia disegnata su un tombino, un muro che respira, una panchina che racconta storie. Tutto questo con un tono fresco, senza zucchero aggiunto. Perché crescere non significa smettere di giocare. Significa iniziare a giocare meglio.